Dal nostro archivio: Saldamente sulle nuvole di Mimmo Jodice e Isabella Pedicini
Pubblicato il : 26/02/2024 15:23:48
Alla vigilia dei novant'anni, che compirà il 29 di questo mese, un omaggio al grande maestro della fotografia Mimmo Jodice. Una vita da romanzo la sua: l’infanzia infelice nel quartiere Sanità di Napoli, le ferite della guerra, l’amore indissolubile per sua moglie Angela, la famiglia, gli amici numerosi e sempre presenti, i viaggi per il mondo e gli incontri fatali, le grandi mostre e i riconoscimenti, gli entusiasmi e gli avvilimenti, gioie e dolori dell’esistenza. Vicende tenute insieme da un unico filo solidissimo che per Jodice è un daimon ineludibile, destino e vocazione, la fotografia; la stessa fotografia di cui racconta l'incontro fatale tra le pagine di Saldamente sulle nuvole, l’appassionato autoritratto in parole che Mimmo Jodice, tra le foto di famiglia e le sue opere, narra in prima persona e affida a Isabella Pedicini.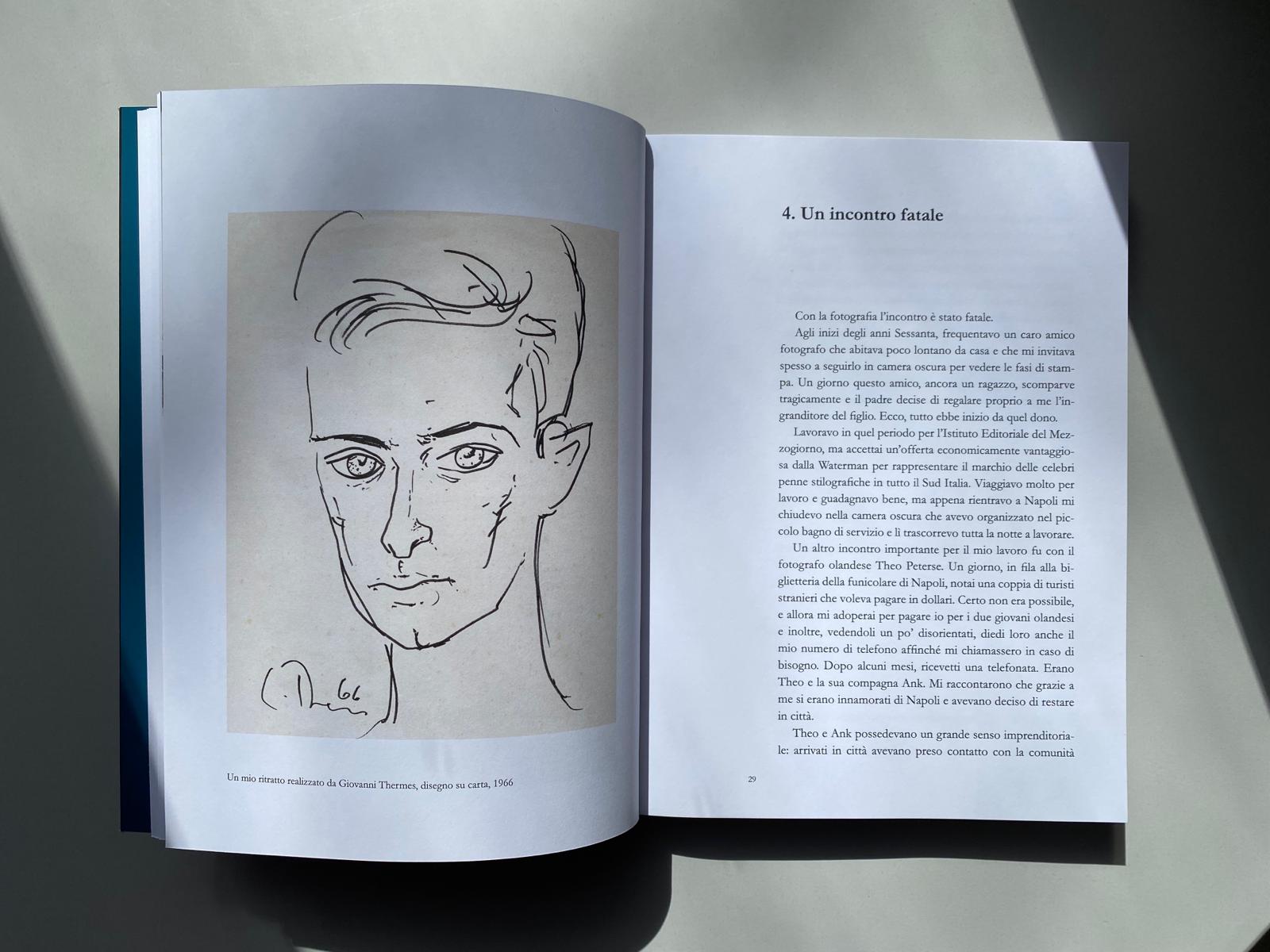
Un incontro fatale
Con la fotografia l’incontro è stato fatale.
Agli inizi degli anni Sessanta, frequentavo un caro amico fotografo che abitava poco lontano da casa e che mi invitava spesso a seguirlo in camera oscura per vedere le fasi di stampa. Un giorno questo amico, ancora un ragazzo, scomparve tragicamente e il padre decise di regalare proprio a me l’ingranditore del figlio. Ecco, tutto ebbe inizio da quel dono.
Paradossalmente, ho cominciato a fare fotografia prima ancora di possedere una macchina fotografica!
Finalmente poi, riuscii a comprare una Canon con alcuni obiettivi e cominciai a fotografare.
In quel periodo, lo stato della fotografia in Italia era molto diverso da oggi. Esistevano infatti solo due principali categorie: i fotografi di mestiere e i fotoamatori. Questi ultimi si riunivano in circoli, pubblicavano sulle riviste fotografiche e partecipavano ai concorsi vincendo premi e medaglie. A livello amatoriale, molti avevano in casa, proprio come me, una piccola camera oscura, ma mi sembrava che appartenessero a un mondo che a me onestamente non interessava.
Per me la fotografia è sempre stata un’altra cosa. Fin dall’inizio, tutto il mio lavoro poggiava su una certezza: la fotografia è una forma d’arte. E se posso attribuirmi un merito in tutti questi anni, è stato senza dubbio quello di aver contribuito a elevare la fotografia a linguaggio artistico. Ora appare scontato, ma quando ho cominciato non era affatto così.
All’inizio, le mie esplorazioni sono state sia di tipo tecnico che linguistico; si sono concentrate sia sui materiali che sulle possibilità espressive del mezzo fotografico. Ho trascorso una vita in camera oscura ed è lì che ho appreso non solo la tecnica, ma il “sapere” legato al mezzo fotografico.
Ho cominciato a sperimentare utilizzando piccole cose che trovavo in giro per casa. Ad esempio, mettevo nel portanegativi un pezzettino di plastica per vedere cosa, una volta stampato, ne venisse fuori. I risultati erano immagini per me incredibilmente belle che mi stupivano e con cui, attraverso prove e tentativi, scoprivo lo strumento e le sue potenzialità.
È stato Paolo Ricci, pittore, giornalista e critico d’arte dell’Unità, il primo al quale mostrai le mie immagini. La nostra era una bella amicizia; frequentavamo la stessa sezione del Partito Comunista, Angela e io eravamo molto giovani ed entusiasti, e lui molto affettuoso con noi. Gli piaceva venire a cena a casa e ogni volta mi chiedeva di mostrargli le mie tele; mi consigliava sulla tecnica, l’uso del colore, della prospettiva e così via.
Una sera, con un po’ di imbarazzo, gli mostrai le mie prime foto. Le guardò a lungo e poi esclamò: “Uaglio’, queste so’ proprio buone! Continua a lavorare. Se ti impegni, possiamo pure fare una mostra”. Per me le sue parole furono di grande incoraggiamento fino a quando, nel 1967, esposi per la prima volta le mie fotografie alla libreria “La Mandragola” di Napoli. La libreria “La Mandragola”, creata da Mario e Maria Luisa Santella, era per noi giovani un luogo meraviglioso e unico dove si parlava di teatro, cinema, poesia, dove era possibile leggere i libri senza doverli acquistare e dove si poteva anche partecipare a laboratori teatrali. Mario e Maria Luisa avevano creato un teatro underground, l’“Alfred Jarry Theatre”, che insieme al “Tin” di Michele Del Grosso in via Martucci rappresentava l’avanguardia teatrale napoletana. Era un teatro alternativo e sperimentale, di grande tensione politica e di un fermento veramente eccezionale.
Così, dal 3 al 15 giugno 1967, vennero esposte, come diceva la locandina, “48 fotografie di Mimmo Jodice”. Il testo di accompagnamento, del critico cinematografico Antonio Napolitano, cominciava così: “Nessuno più dubita, oggi, che la fotografia sia uscita di minorità, confermando la sua stretta parentela con la pittura e ribadendo la sua capacità di convogliare emozioni, convinzioni, interpretazioni” e continuava parlando del mio lavoro che “sa di lunga attesa, quella bruciante e travagliata attesa che solo concede di catturare la luce giusta”. Già allora l’attesa diventava un elemento fondamentale della mia fotografia.
Nella locandina della mostra si verificò un fatto bizzarro che ha segnato poi interamente la mia carriera: il mio cognome, che all’anagrafe risulta “Iodice”, comparve scritto con la J. Si trattò chiaramente di un refuso di stampa, poiché nel titolo della mostra ero Jodice, mentre nel testo di Napolitano ero Iodice. Questo errore involontario, però, mi divertì molto e piacque anche ad Angela, sicché da quel momento decisi di adottare “Jodice” trasmettendolo, poi, a tutta la mia famiglia.
L’anno successivo, il 1968, fui invitato a esporre a Urbino, al Teatro Spento, e la mia mostra fu presentata da Carlo Bo. Ricordo che con Angela eravamo emozionatissimi!
In quell’occasione Paolo Ricci, sulle pagine dell’Unità, parlando della mia mostra ricordò il mio rapporto con la scena teatrale napoletana, soprattutto con il gruppo “Vorlesungen” diretto da Mario Santella, con cui avevo a lungo collaborato realizzando molte delle immagini in mostra a Urbino. Ricci colse il nocciolo della mia ricerca, quando scrisse che “abbandonando ogni comodo rifugio nella immagine naturalistica, Mimmo Iodice guarda la realtà per coglierne facce inesplorate”.
In quegli anni, invitati da nostri amici pianisti, i fratelli Campanino, andavamo qualche volta nel più elegante night club di Napoli, “La Mela”, frequentato dalla Napoli bene e da ragazze bellissime ed eleganti. Mi venne voglia di ritrarle. Per me rappresentava una grande novità. Praticamente, passavo dai vicoli al ritratto!
Così, nel maggio 1969, esposi nella libreria Deperro di Napoli “Persona”, una serie di ritratti femminili accompagnati da una presentazione di Michele Prisco, che a proposito dei miei ritratti scrisse che non si guardano ma “si leggono” e della mia “ricerca umana tesa a restituirci, d’un volto, quello che vi si cela dietro, o dentro”. Fu un successo straordinario: tutti volevano un ritratto realizzato da me e lo avrebbero pagato bene. Ma io consideravo quella solo una nuova esperienza, un modo per capire le grandi e diverse possibilità della fotografia; non volevo diventare ritrattista. Regalai alle ragazze le loro foto e, da quel momento, non ho voluto più realizzare ritratti.
Intanto continuavo a lavorare come rappresentante. Si trattava di un impiego molto impegnativo, ma che mi permetteva di guadagnare bene. Angela insegnava e stava per nascere Francesco.
Avevamo una bella casa e potevo concedermi anche piccole follie, come l’acquisto di un’automobile lussuosa, un’Alfa Romeo Sprint Special, di un’apparecchiatura ad alta fedeltà per ascoltare la musica classica, e di una Mini Minor per Angela.
Nel frattempo, dal bagnetto di servizio avevo trasferito la camera oscura in camera da letto, dove avevo sistemato due ingranditori, le bacinelle per lo sviluppo e il fissaggio – il “pollaio”, così lo chiamavamo – per asciugare le foto. In questa stanza mi rinchiudevo appena tornavo dal lavoro. Ero felice perché amavo Angela, avevo una famiglia splendida, un buon lavoro, una bella casa. Ma non ero sereno. Nel profondo ero tormentato: da ragazzo ero stato costretto a lasciare la scuola, avevo sempre amato dipingere e disegnare e avevo dovuto rinunciare a queste passioni. Adesso dovevo rubare ore alla famiglia e al riposo per seguire la fotografia. Angela comprese la mia ansia e, ancora una volta, il dramma di dover rinunciare a qualcosa di profondo dentro di me. Lei ebbe il coraggio che io non avrei mai avuto: nonostante finalmente avessimo raggiunto una tranquillità economica mai avuta prima, mi convinse a lasciare il lavoro e a tentare di seguire il mio sogno.
Avevo appena vinto il premio come migliore venditore dell’anno e la sua idea mi sembrò una follia. Eppure, mi convinse e mi costrinse a licenziarmi.
Seguirono 3-4 anni durissimi, ma Angela non si pentì mai della scelta fatta. I nostri figli erano molto piccoli e l’unico stipendio in casa, ormai, era il suo di docente della scuola pubblica. “E se dovesse andare male?”, le chiedevo. Lei allora, con grande sicurezza e grande forza, rispondeva che se fosse andata male, avrei subito trovato un nuovo impiego perché ero molto bravo.
Del resto, entrambi avevamo conosciuto realmente la fame ed eravamo riusciti a sopravvivere. Angela e io avevamo spalle forti, non avevamo paura di osare, né di cadere. Cosa avremmo potuto perdere?
